
Alcuni giorni fa, quasi per caso, sono passato per Campo Felice, stazione sciistica intorno ai 2000 m s.l.m. che si trova nel territorio del Monte Velino, appena fuori L’Aquila. Campo Felice, da sempre promossa con lo slogan “un mare di sole e di neve”, è un luogo amato anche dai romani, dato che in poco più di un’ora di automobile dalla capitale ci si trova su piste che, pur non essendo all’altezza di quelle alpine, offrono un debito svago sciistico.

Quando ero studente nella Facoltà di Architettura di Roma, quasi trent’anni fa, mi capitava ogni tanto di andare la mattina a sciare lì per poi scendere in aula il pomeriggio. Mancavo da un po’ di anni – non moltissimi per la verità – ma lo spettacolo che mi si è parato davanti è stato veramente sorprendente, benché non del tutto inatteso: nei primissimi giorni di gennaio, in una giornata dal clima quasi primaverile, sul comprensorio sciistico non si vedeva un solo fiocco di neve.


Il giorno seguente, sull’edizione bolognese di “Repubblica”, compariva un articolo dedicato all’analoga situazione che si sta verificando sull’Appennino emiliano, rimasto anch’esso completamente a secco. In particolare, veniva riportata la notizia dell’intenzione della Giunta Regionale di promuovere l’installazione di innovativi cannoni sparaneve, capaci di garantire un manto bianco anche con alte temperature – tecnologia che è stata sviluppata per i Giochi Asiatici del 2029, che si terranno nella località di Trojena, a 50 km dal Golfo di Aqaba, in Arabia Saudita.
Esatto, in Arabia Saudita.

Appare chiaro che la trasformazione del clima comincia a farsi sentire in maniera tangibile; se da un lato assistiamo a processi di tropicalizzazione – come sappiamo sta avvenendo, ad esempio, a Roma – dall’altro alcuni territori procedono a passo spedito verso la desertificazione. Ora, se ragionando secondo i canoni della geografia ottocentesca, interessata alla materialità dei territori, la selva e il deserto sono due tipologie di paesaggio naturale tassonomicamente opposte, forse in una logica contemporanea, meno protervamente oggettiva, entrambe ricadono in una medesima categoria affettiva. Selva e deserto sono entrambi luoghi oscuri, misteriosi, perturbanti, ricchi tanto di fascino quanto di minacciosità: sono territori dove non ci si inoltra, a meno di condizioni del tutto particolari dell’esistenza – chi, per esempio, ha un cuore di tenebra – e anche in quel caso spesso solo sfiorandone i margini, scrutando verso l’interno da una posizione arretrata e protetta, dalle retrovie. Il ragionamento sulla selva, dunque, di cui questa mostra è una costola, come anche i deserti italiani che avanzano senza che nessuno possa fare molto per arrestarne il movimento, mostrano i limiti oltre i quali noi non possiamo andare: il non progettabile.
Posizionare dei cannoni da neve in Arabia Saudita, operazione degna del dadaismo o anche dei Monty Python, incarna una sfida estrema al non progettabile, manifestazione della stessa caparbietà in virtù della quale l’uomo è arrivato sulla Luna o sul fondo degli oceani. I limiti del progettabile – intendendo per progetto, in senso molto lato, l’attitudine a trasformare il mondo, sino a rendere possibile ciò che non era precedentemente possibile – si possono, in linea teorica, perennemente spostare in avanti, conquistando avamposti sempre nuovi, in territori ancora non esplorati. Territori, sia chiaro, non topografici, giacché il pianeta è ormai tutto mappato nel dettaglio più voyeuristico, ma territori del possibile, del I can che definisce il concetto stesso di azione. Questi limiti possono essere spostati verso orizzonti teoricamente infiniti, rendendo possibile qualsiasi cosa, incluso lo sciare nel torrido deserto dell’Arabia Saudita.
Probabilmente, portare la neve artificiale (e di conseguenza gli sciatori) sull’Appennino, come anche riorganizzare la vita delle isole della laguna veneziana, pur rappresentando uno spostamento non indifferente dei nostri limiti di azione, non è un’ipotesi veramente estrema, come camminare sulla Luna. È chiaro che ci si può interrogare sulla liceità e ragionevolezza di tali interventi, sull’impatto pazzesco che avrebbero sul paesaggio, sul consumo di suolo, acqua, energia, sull’inquinamento; ma sul piatto della bilancia c’è, chiaramente, anche un’ulteriore fetta di economia italiana che rischia di sparire, seguendo le orme di molte altre industrie che se ne sono ormai andate. Forzare i limiti del progetto, trasformando il mondo oltre quanto potrebbe apparire ragionevole, può anche significare la sopravvivenza delle persone e dei territori antropizzati.
I progetti dell’Isolario ideato da Sara Marini sondano, ciascuno per il proprio verso, i limiti del progetto, ridefinendo, almeno per la laguna veneziana, che cosa possa definirsi progettabile. La varietà delle proposte è impressionante, fatto che può essere ambivalentemente interpretato come sintomo di ottima salute della progettazione architettonica nelle università italiane, oppure della sua totale disintegrazione. L’armamentario adottato dai 48 gruppi raccoglie praticamente tutto il potenziale ideativo del progetto di architettura, moderno e non: dal disegno alla fotografia alla grafica pubblicitaria, dall’immaginazione al realismo, dall’ironia al sarcasmo, dall’ottimismo (anche un po’ ingenuo) al pessimismo (anche un po’ depresso), dalla costruzione rudimentale a quella supertecnologica, dai luoghi performativi ai monumenti, dai segni massimalisti alle delicate acupunture, dalla poesia alla prosa. In un magnifico mash-up trans-generazionale e inter-disciplinare, non ci facciamo mancare niente. L’allegra confusione che deriva da questa kermesse dedicata all’esplorazione dei limiti del progettabile intravede per la laguna un futuro molteplice, dai contorni sfumati, dove a progetti canonicamente vitruviani si affiancano costruzioni spaziali sofisticate, pensate per mettere in scena esperienze fenomenicamente insolite, derive situazioniste o neo-bucoliche, nonché paesaggi post-apocalittici.
L’Isolario è chiaramente una provocazione, perché chiede ai progettisti di dedicare attenzione a luoghi scartati, dimenticati, percepiti come remoti benché ubicati a poca distanza da una città trafficata come Venezia. E, al di là degli innumerevoli orientamenti, dei modi di entrare in contatto con le isole della laguna, quanto tutti sembrano affermare, convintamente, è: si può fare. I limiti del progetto possono estendersi, proponendo soluzioni adeguate a ciascuna isola, visioni capaci di ribaltarne le sorti, di riportare a galla quanto ormai sembrava affondato. Poco importa se molti progetti sembrano fare affidamento alle teorie della cosiddetta extenics – la curiosa scienza che lavora sull’estensione delle regole e dei modelli formali per affrontare problemi di natura contraddittoria – e alcuni, forse anche più simpaticamente, alla patafisica. Parimenti allo slancio di invenzione dell’utopia, questi progetti gettano il cuore oltre l’ostacolo della realtà, ma non tanto per immaginare mondi lontanissimi, quanto piuttosto per districarsi dall’intreccio della selva che langue nella laguna.
A questo punto, tuttavia, sorge un dubbio. Il progetto, per come viene praticato dagli architetti, per come lo si vede esposto nelle tavole della mostra, per come è ontologicamente tematizzato, è veramente capace di prevedere e conseguire ogni trasformazione del mondo? A ben vedere, questa appare per certi versi un’affermazione carica di ottocentesco ottimismo positivista, di fiducia incrollabile negli strumenti di controllo della realtà, una realtà percepita come cristallina, apollinea. Che progettare possa poi provocare un fallimento è un’evidenza tanto lampante che non richiede prova alcuna – sul breve o sul lungo termine, a volte l’architettura semplicemente non si compie. Anche fra le tavole dell’Isolario, tutto sommato, è facile immaginarsi tanti progetti che non si compiono: ferri che rimangono in attesa, grandi circonferenze incompiute, serramenti non montati, arredi rimasti nel cellophan, tutte testimonianze di un mondo che resiste tenacemente ai nostri tentativi di trasformazione. Non che questa sia necessariamente una ragione per non progettare – molti progetti, lo sappiamo, rimangono sulla carta, e chissà che fra mille anni qualche archeologo di un futuro post-apocalittico non scopra una copia superstite del catalogo curato da Marini e Moschetti, e che questo non diventi il fondamento di una reinvenzione di Venezia nel quarto millennio d.C., una specie di rediviva pianta del Nolli lagunare. Le ragioni più profonde del nostro agire, come sosteneva Mies van der Rohe, sono da rintracciarsi nelle conversazioni di frati nel silenzio dei chiostri romanici: forse oggi si stanno piantando i semi di qualcosa che germoglierà quando noi non ci saremo.
Eppure, al di là di questa visione vagamente chiliastica di un mondo in procinto di essere distrutto – quella che si ha, insomma, ogni volta che si accende il televisore sul canale delle breaking news – permane il dubbio che una revisione sostanziale del paradigma del progetto non sia più differibile. Se questo non avverrà nel mondo delle cose vere – già vedo Bonaccini inaugurare i futuribili cannoni sparaneve arabi sulle piste dell’Abetone – almeno occorre che se ne parli nelle scuole di architettura che tutt’ora rappresentano un presidio culturale, dove si immaginano l’architettura e i territori del futuro. Occorre articolare il dubbio che il progetto sia solo una delle possibili strade da percorrere, non l’unica: e che se noi in quanto architetti non riusciamo ad immaginarne altre, allora forse il difetto, come si diceva un tempo, sta nel manico.
Progettare, come forma epistemica, significa prendere il controllo: prevedere il futuro, orientarne il corso, imporre il dominio dell’uomo. Significa, come abbiamo appreso dal catechismo, “Riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra”. Adesso, se “soggiogatela” può già sembrare un termine non proprio gentilissimo, andare a rintracciare i significati dell’originale termine aramaico – kabash – fa rizzare i capelli in testa: soggiogare, sottomettere, forzare, trarre in catene, asservire, violare, dominare, ecc. Non è esattamente l’interpretazione che darebbe Famiglia Cristiana, ma dà conto dell’inevitabile violenza che il progetto spesso incarna, della continua violazione del mondo alla quale siamo talmente assuefatti da non farci praticamente più caso. Estendere i limiti del progettabile, esplorare nuovi territori e insediare nuovi avamposti implica creare colonie, e le colonie non si fondano mai senza forza. Se Mies riconduceva le origini del nostro modo di essere a tempi medievali, nel cuore dell’Europa teutonica, aveva ragione ma anche un po’ torto: forse doveva gettare lo sguardo ben più indietro, a osservare come popoli di pastori nella Palestina dell’età del ferro combattevano fra loro per una striscia di terra, e lo scontro fra ittiti, achemenidi, assiri, israeliti, cananei e cento altre popolazioni contendenti ha dato vita ad un paesaggio di violenza di cui ancora troviamo traccia nei testi antichi che hanno fondato la cultura occidentale. Forse la violenza intrinseca nel progetto nasce dai nostri bellicosi antenati; forse semplicemente dal fatto che siamo violenti come specie, e non sappiamo fare altrimenti.
Il lavoro sulla selva veneziana, mi pare, invita a riflettere proprio su questo: su quanto sia opportuno e necessario progettare oltre, dando sfogo alla pressione colonizzatrice che viene dal nostro profondo, o se non sia più congruo attendere che le cose avvengano, sostituendo alla praxis del progettare il pathos esistenziale che ci vede non più tanto soggetti di quanto semmai soggetti a gli avvenimenti del mondo, in una postura affettiva polarmente ribaltata, una sorta di “ritirata” dalla violenza che abbiamo ereditato dai nostri antenati. Se l’Isolario non prelude strettamente a questo, almeno lascia lo spazio perché il progetto possa essere “messo in mora”, perché il non progettabile rimanga proprio quello che è, il territorio della selva o del deserto, luogo nel quale non ci è propriamente consentito entrare, se non in maniera clandestina o camuffati.
In ultima analisi, stiamo parlando di un’istanza etica, che impone che tutti quanti si occupano di progetto, nelle sue innumerevoli declinazioni, da noi che lo insegniamo ai nostri studenti che imparano a praticarlo – tutti quelli che non devono preoccuparsi direttamente dei posti di lavoro sull’Appennino – si interroghino sulla violenza del progetto, sulla natura del non progettabile, e sull’opportunità di riconoscerne e rispettarne i limiti. Mantenendo forse anche – come non ho fatto io – un pizzico di ottimismo, dato che ieri sera, proprio mentre finivo di scrivere questi appunti, a Campo Felice – e su tutto l’Appennino – è finalmente scesa la neve.
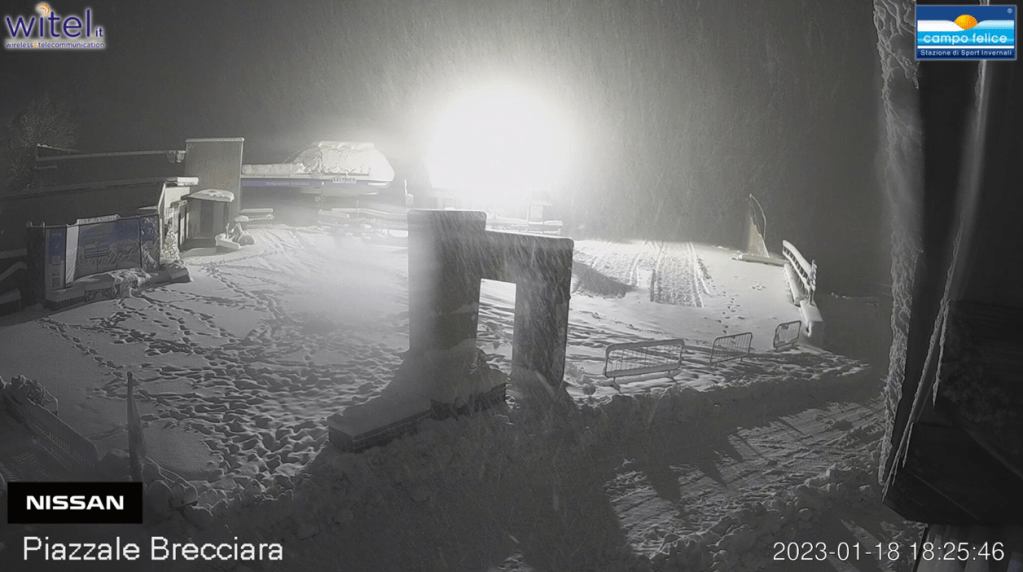
Relazione presentata al Seminario Isolario Roma, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, 19 gennaio 2023.
